Come la Rai ha stravolto la realtà
della mitica Spedizione dei Mille
Li ha dipinti analfabeti: erano quasi tutti studenti e professionisti
In totale erano 1089 e venivano dalle regioni del Nord tranne 71 siciliani
di Rino Di Stefano
(Il Giornale, Martedì 6 Marzo 2007)
 Che la televisione sia ormai il maggior contenitore di spazzatura mediatica in circolazione, è una verità che non ha neppure bisogno di essere dimostrata. Certamente c’è televisione e televisione: se una trasmissione è volutamente popolare e ha l’unica ambizione di intrattenere un pubblico di bocca buona, cercare chissà quali contenuti culturali diventa pretenzioso e snobbistico. La questione invece cambia se un ente pubblico come la Rai trasmette una fiction del tipo «Eravamo solo mille» che lo scorso dicembre aveva la pretesa di ricordare l’epopea garibaldina con «un racconto per immagini – si leggeva a gennaio su La Stampa – che non solo è sciatto, dozzinale, impreciso e infedele, ma che soprattutto, in nome dell’ “intrattenimento”, è incapace di restituire la verità mitica del Risorgimento».
Che la televisione sia ormai il maggior contenitore di spazzatura mediatica in circolazione, è una verità che non ha neppure bisogno di essere dimostrata. Certamente c’è televisione e televisione: se una trasmissione è volutamente popolare e ha l’unica ambizione di intrattenere un pubblico di bocca buona, cercare chissà quali contenuti culturali diventa pretenzioso e snobbistico. La questione invece cambia se un ente pubblico come la Rai trasmette una fiction del tipo «Eravamo solo mille» che lo scorso dicembre aveva la pretesa di ricordare l’epopea garibaldina con «un racconto per immagini – si leggeva a gennaio su La Stampa – che non solo è sciatto, dozzinale, impreciso e infedele, ma che soprattutto, in nome dell’ “intrattenimento”, è incapace di restituire la verità mitica del Risorgimento».
I genovesi, ma non solo loro, si sono sentiti offesi da quella blasfema ricostruzione di un periodo che è stato tra i più eroici della storia italiana. A vedere quella ridicola commediola televisiva, sembrava che i Mille fossero un branco di analfabeti avventurieri, soprattutto nativi dell’Italia meridionale, che tornavano a casa per fare i conti con i nemici borbonici.
La realtà era un po’ diversa. Tanto per cominciare, i Mille non furono proprio Mille. Per essere esatti erano 1089 e la lista precisa, fornita dal Ministero della Guerra, fu pubblicata nel 1864 dal Giornale Militare quale risultato di un’inchiesta che era stata istituita dal Comitato di Stato per accertare con precisione chi partecipò alla storica spedizione. Si venne così a sapere che la maggior parte dei volontari erano lombardi (434), veneti (194), liguri (156), toscani (78), siciliani (71), stranieri (35). Pochissimi i piemontesi, che non arrivavano a una decina.
 Variegata, ma tutt’altro che bassa, la composizione sociale: 150 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti, 50 ingegneri, 60 possidenti, circa 500 tra artigiani e commercianti. A bordo del «Piemonte» e del «Lombardo» solo una donna: la moglie di Francesco Crispi.
Variegata, ma tutt’altro che bassa, la composizione sociale: 150 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti, 50 ingegneri, 60 possidenti, circa 500 tra artigiani e commercianti. A bordo del «Piemonte» e del «Lombardo» solo una donna: la moglie di Francesco Crispi.
Con la legge n.2119 del 22 gennaio 1865, ogni reduce ricevette la pensione e potè fregiarsi della medaglia che il Consiglio comunale di Palermo istituì il 21 giugno 1860.
Gli autori della fiction non si sono presi neanche la briga di informarsi e di capire che cosa c’era dietro quella spedizione. Non si sono posti il problema di quei tanti giovani che, in nome di un’Italia unita, si imbarcarono in un’avventura che a molti di loro costò la vita. Certo che in un momento in cui questo Paese è diviso come non mai tra Nord e Sud, Centro e Nord Est, pochi si pongono il problema di quel sangue versato per un’ideale di nazione sovrana non soggetta al dominio straniero.
Vediamo dunque di capire qualcosa di più su chi erano in realtà quei Mille giovani e, per farlo, facciamocelo spiegare dalle parole di colui che fu il primo artefice di quel periodo: Giuseppe Garibaldi. C’è infatti un’opera dell’Eroe dei due mondi, «I Mille», che è stata diffusa in pochissime copie e che venne pubblicata integralmente soltanto nel 1933 quando Donna Clelia Garibaldi regalò il manoscritto originale all’Archivio del Museo del Risorgimento. Di questo libro sappiamo che venne scritto dal generale tra il 1870 e il 1872, mentre risale al 21 gennaio 1873 la prefazione, sempre a firma di Garibaldi, «Alla Gioventù italiana».
Il manoscritto venne rifiutato da vari editori per il contenuto piuttosto forte, soprattutto nei riguardi della Francia, e venne pubblicato in una prima versione nel 1874 in pochi esemplari, dagli editori Camilla e Bertolero di Torino, grazie all’aiuto economico di un gruppo di sottoscrittori. I loro nomi vennero elencati in ordine alfabetico in fondo all’opera.
Il libro, dove Garibaldi non le manda a dire a nessuno ma affronta di petto tutti i suoi nemici, nasce dalle polemiche che in quegli anni fiorivano tra Mazzini e lo stesso Garibaldi. Non correva buon sangue tra i due, in particolare per le critiche che venivano rivolte da certi ambienti alla spedizione del 1860, un ‘impresa che già allora era considerata leggendaria dai contemporanei. Bisogna inoltre aggiungere che intorno al 1870 vi fu una recrudescenza dell’anticlericalismo in Italia, mentre la dottrina di Mazzini volgeva ormai al termine, nel senso politico del termine.
Si presume che queste notizie venissero riportate a Garibaldi, in «esilio» nella sua Caprera, dal genero Stefano Canzio. E infatti il generale rispose con lettere aperte che ancora oggi sono notevoli per i loro contenuti storici. Tra l’altro cominciava a profilarsi all’orizzonte anche l’ideale socialista e Garibaldi ne prese parte affermando che l’Internazionale socialista gli sembrava una società perfetta «che ha l’audacia di voler la fratellanza di tutti gli uomini a qualunque nazione essi appartengono, che non vuole preti, non eserciti permanenti, non caste privilegiate».
Ce n’era abbastanza per suscitare le reazioni dei benpensanti, dei monarchici e dei clericali che in quel vecchio generale, ormai prossimo a lasciare i dolori di questa terra, vedevano la sintesi di tutti i loro nemici. Garibaldi morirà a Caprera nel 1882 e quindi ebbe modo di gioire nel 1877 quando i bersaglieri entrarono dalla breccia di Porta Pia, segnando la fine dello stato pontificio e la riunificazione di Roma all’Italia. C’è da chiedersi che cosa avrebbe pensato se avesse potuto vedere l’Italia di oggi.
In un volume di Garibaldi del 1874 tutta la verità sulla storica avventura
I Savoia sequestrarono le carabine
Il generale racconta di quando i volontari sgominarono l’esercito borbone con “vecchi catenacci”
 Una delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille», è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca.
Una delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille», è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca.
Peccato che nella realtà il fatto avvenne di notte e i Mille fossero suddivisi tra la Foce e Quarto, con il grosso del gruppo in attesa su quello che Garibaldi chiama il «promontorio di Quarto». Ma ecco le sue parole:
«O notte del 5 Maggio, rischiarata dal fuoco dei Mille luminari, con cui l’Onnipotente adornò lo spazio! Bella, tranquilla, solenne di quella solennità che fa palpitar le anime generose, che si lanciano all’emancipazione degli schiavi! Io ti saluto! E vi saluto, o miei compagni giovani, oggi provetti e maggior parte mutilati o segnati con gloriosissime cicatrici».
Il generale è un po’ aulico e si commuove pensando a quella notte in cui lui e la sua «banda», come erano chiamati, trepidavano sugli scogli aspettando di vedere all’orizzonte i due vapori «Piemonte» e «Lombardo», partiti dalla vecchia darsena, oggi Porto Antico.
«Eccoli! Eccoli! E maestosi s’avanzavano i due piroscafi, e i gozzi, già preparati, cominciavano ad imbarcare militi, armi, munizioni; e la gioia dei giovani volontari, che avrebbero voluto manifestarla almeno con un canto patriotico, era moderata dai più provetti con un “Per Dio! ci fermano se fate chiasso!”. E quei prodi religiosamente tacevano, per non essere sviati dalla santa impresa!».
Garibaldi si lamenta quindi del contrabbando fatto delle merci che servivano alla spedizione e che, per un soffio, non l’avevano fatta fallire.
«E veramente la spedizione dei Mille fu compromessa da quel turpe mercato. E come non doveva essere? Essa doveva sbarcare su un’isola, i cui abitanti erano forse unici per patriottismo e per risoluzione. Ma la Sicilia non aveva meno di cinquanta mila scelti soldati, una squadra formidabile che ne difendeva le coste, ed i valorosi che s’erano innalzati contro il tiranno, decimati dai combattimenti e ridotti agli estremi. Approdar con tutto ciò senza munizioni da guerra e coi mille catenacci che la benevolenza governativa avea concessi, in sostituzione di 15 mila buone carabine, che erano di proprietà nostra e dal governo sequestrate!».
Non sarà la prima volta che Garibaldi se la prende con Cavour e con i Savoia, arrivati al punto di sequestrare le armi nuove per evitare che si potesse dire che il governo avevano armato la spedizione.
Il giorno dopo, il 6 maggio, i due piroscafi raggiunsero il porto di Talamone dove si trovava un deposito di munizioni. Per evitare uno scontro armato, Garibaldi usò uno stratagemma: si presentò nella sua divisa da generale dell’esercito sardo. Quando l’ufficiale di turno se lo trovò davanti, si mise sull’attenti e fornì senza fiatare le munizioni di cui la spedizione aveva bisogno. «Quel bonetto da generale agli occhi dell’Ufficiale veterano, ebbe un effetto stupendo e metarmorfosò in un momento il capo rivoluzionario in Comandante legale», racconta.
 Ad un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia e il secondo di Bergamo. Era l’ora del rancio e gli altri erano fermi a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora – scrive Garibaldi – era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».
Ad un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia e il secondo di Bergamo. Era l’ora del rancio e gli altri erano fermi a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora – scrive Garibaldi – era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».
La liti finì con un imprevisto quando uno dei volontari, che già aveva accusato problemi mentali, si buttò in mare per tentare il suicidio. «Il salvato dall’onde manifestò alcuni segni di pazzia e forse egli si gettò col proposito di raggiungere il Lombardo che veniva dietro il Piemonte; la freschezza del mare però, tornandolo a più savi consigli, egli mostrossi espertissimo nuotatore, lottando per ragiungere il palischermo che vogava alla di lui direzione». Successivamente l’uomo tentò un’altra volta di uccidersi quando la nave arrivò in vista delle coste siciliane, e quella volta il nuovo tentativo mandò davvero in bestia il generale.
E finalmente giunsero a Marsala. Garibaldi ricorda che i suoi furono subito aiutati dai marinai dei «legni mercantili» ancorati nel porto e che subito dopo il generale Turr marciò con una compagnia verso la città, dove i volontari furono accolti senza la benché minima resistenza. «Intanto i Mille sfilavano, coperti dal molo e poco curando una pioggia di granate e mitraglie, che il naviglio borbonico inviava a profusione e che per fortuna non cagionò feriti».
E si arriva così al primo e fondamentale scontro armato, alla battaglia di Calatafimi, all’alba del 15 maggio, quando si decise concretamente quello che sarebbe stato il futuro della spedizione. I Mille, cui si erano aggiunti un buon numero di «picciotti» inviati dai fratelli Giuseppe e Stefano Triolo, baroni di Sant’Anna e dal possidente Giuseppe Coppola (denominati «Cacciatori dell’Etna»), erano ormai circa 2000. Di fronte si trovarono 3344 soldati borbonici comandati dal generale Landi, dei quali 2172 sul campo di battaglia e altri 1172 in retroguardia nel paese di Calatafimi.
I borboni si assestarono su una collina chiamata «Pianto dei Romani, ove esiste la tradizione esser stati i Romani disfatti in quel sito dai Siciliani, collegati alla potente popolazione di Segeste, di cui si scoprono le ruine, non lontane al Settentrione».
I garibaldini, invece, si posizionarono sul colle di Petralonga schierando i carabinieri genovesi in avanguardia. Dietro c’era il secondo battaglione agli ordini di Nino Bixio. Garibaldi e il tenente generale Giuseppe Sirtori ordinano un primo attacco a mezzogiorno e «i Napolitani sono ricacciati sull’altura a passo di corsa». E vi fu il primo caduto: «Comunque già i prodi Liguri avevano un morto e vari feriti».
Alle 14 scatta il secondo attacco garibaldino con il maggiore Acerbi che conduce i suoi ragazzi e un piccolo corpo di squadriglie siciliane contro il nemico. Respinti, i napoletani si riuniscono nella seconda altura e da lì fanno fuoco, dall’alto verso il basso, contro gli uomini di Garibaldi. Ma l’impeto è inarrestabile.
«Come foriero di vittoria, uno squillo di tromba nostra suonò una sveglia Americana e la vanguardia nemica, come per incanto, fermossi e forse i suoi capi si pentirono d’aver avanzato tanto. I Borbonici capirono di non aver da fare colle sole squadre e le loro catene cominciarono un movimento retrogrado. I Mille toccarono allora la carica, i carabinieri Genovesi in testa e con loro un’eletta schiera di giovani non appartenenti alle compagnie, ed impazienti di menar le mani. L’intenzione della carica era di fugar la vanguardia nemica e d’impossessarsi dei pezzi, ciocché fu eseguito con un impeto degno dei campioni della libertà Italiana; non però di attaccare di fronte le formidabili posizioni occupate dal nemico con molte forze. Però chi fermava più quei focosi e prodi volontari, una volta lanciati sul nemico? Invano le trombe toccarono Alto! I nostri, o non le udirono, o fecero i sordi e portarono a bajonettate la vanguardia nemica sino a mischiarla col grosso delle forze borboniche, che coronavano le alture».
 La situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi rispose: «Qui si fa l’Italia o si muore». Nella realtà pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».
La situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi rispose: «Qui si fa l’Italia o si muore». Nella realtà pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».
E fedele al suo principio che quando si è iniziata una battaglia non bisogna mai mollare per nessuna ragione, Garibaldi ordinò il terzo e più violento attacco della giornata. Erano le 3 del pomeriggio. E i volontari garibaldini, armati di vecchi fucili che spesso non funzionavano neppure, stavano annientando un esercito di soldati professionisti e ben armati. «Mi fa ribrezzo il ricordarlo – scrive il generale- i catenacci con cui ci aveva regalato il governo sardo, ci negavano fuoco, e si scorgeva il dispetto sull’eroiche fisionomie di quei giovani, che spero prenderà ad esempio la generazione che segue, destinata a compiere l’opera santa. Qui pure fu grande il servizio reso dai figli della Superba! che, armati delle loro buone carabine, sostenevano l’onere delle armi. Tutti poi, corrispondendo all’intemerata risoluzione di andar avanti, finirono coll’affidarsi al freddo ferro delle loro bajonette».
Fu l’inizio della fine del dominio borbonico sull’Italia meridionale. Da quel momento in poi, infatti, l’avanzata dei Mille, che presto si trasformarono in diverse migliaia con l’arrivo di altri volontari da ogni dove, portò all’unificazione del territorio italiano sotto il regno dei Savoia, completato più tardi con l’annessione del Regno Pontificio.
Un’altra stupidata della fiction è quella di aver dipinto i Mille con la camicia rossa dei garibaldini. Non era così, e lo testimonia lo stesso Garibaldi. «I Mille, vestiti in borghese, degni rappresentanti d’una nazione oppressa, assaltavano, col sangue freddo dei trecento di Sparta e di Roma, un nemico numeroso, di posizione in posizione e formidabile, ed i soldati della tirannide, brillanti di pistagne e spalline fuggivano davanti a loro».
Quei giovani fecero la storia. «Calatafimi! – scriverà infine Garibaldi – Io, avanzo di tante pugne, se all’ultimo respiro i miei amici vedrammi sorridere l’ultimo sorriso d’orgoglio, esso sarà ricordando. Tu fosti il combattimento di popolo più glorioso!».
Nella battaglia di Calatafimi persero la vita 41 garibaldini, tra i quali anche il camoglino Simone Schiaffino, 25 anni, timoniere del «Lombardo» e componente del quartier generale di Garibaldi, che l’analfabetismo storico degli autori Rai (quello sì, autentico) ha fatto passare per analfabeta. Schiaffino morì andando all’attacco con la bandiera dell’Italia in mano, trafitto da numerosi colpi.
I feriti tra i garibaldini furono 126. I morti tra le squadre siciliane furono 6, una ventina i loro feriti. I borbonici lasciarono sul campo una trentina di soldati ed ebbero 62 feriti.
Su quello stesso colle dove i volontari di Garibaldi sconfissero i borbonici, adesso sorge un monumento ossario dove sono conservati i resti di tutti quei giovani che donarono la vita per unificare l’Italia. Sarebbe bello che in questi giorni, celebrando i duecento anni dalla nascita di Garibaldi, qualcuno avesse un pensiero anche per loro.
R.D.S.
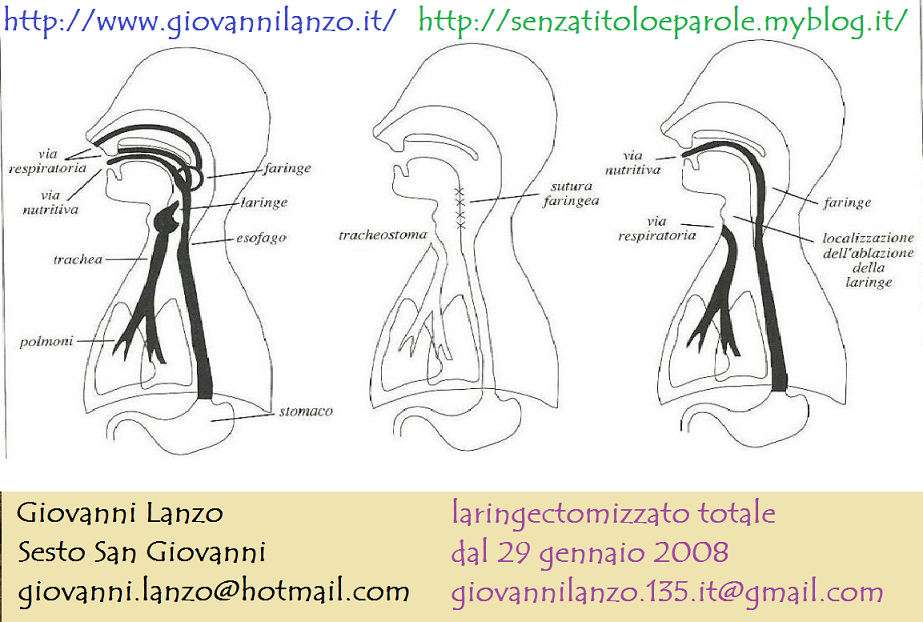

 Niente canone Rai per i possessori di computer
Niente canone Rai per i possessori di computer Viva la Rai: Gubitosi ha il posto fisso
Viva la Rai: Gubitosi ha il posto fisso










































 Verso Sanremo: intervista ad Arisa
Verso Sanremo: intervista ad Arisa Verso Sanremo: intervista a Francesco Renga
Verso Sanremo: intervista a Francesco Renga Le 5 serate
Le 5 serate Che la televisione sia ormai il maggior contenitore di spazzatura mediatica in circolazione, è una verità che non ha neppure bisogno di essere dimostrata. Certamente c’è televisione e televisione: se una trasmissione è volutamente popolare e ha l’unica ambizione di intrattenere un pubblico di bocca buona, cercare chissà quali contenuti culturali diventa pretenzioso e snobbistico. La questione invece cambia se un ente pubblico come la Rai trasmette una fiction del tipo «Eravamo solo mille» che lo scorso dicembre aveva la pretesa di ricordare l’epopea garibaldina con «un racconto per immagini – si leggeva a gennaio su La Stampa – che non solo è sciatto, dozzinale, impreciso e infedele, ma che soprattutto, in nome dell’ “intrattenimento”, è incapace di restituire la verità mitica del Risorgimento».
Che la televisione sia ormai il maggior contenitore di spazzatura mediatica in circolazione, è una verità che non ha neppure bisogno di essere dimostrata. Certamente c’è televisione e televisione: se una trasmissione è volutamente popolare e ha l’unica ambizione di intrattenere un pubblico di bocca buona, cercare chissà quali contenuti culturali diventa pretenzioso e snobbistico. La questione invece cambia se un ente pubblico come la Rai trasmette una fiction del tipo «Eravamo solo mille» che lo scorso dicembre aveva la pretesa di ricordare l’epopea garibaldina con «un racconto per immagini – si leggeva a gennaio su La Stampa – che non solo è sciatto, dozzinale, impreciso e infedele, ma che soprattutto, in nome dell’ “intrattenimento”, è incapace di restituire la verità mitica del Risorgimento». Variegata, ma tutt’altro che bassa, la composizione sociale: 150 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti, 50 ingegneri, 60 possidenti, circa 500 tra artigiani e commercianti. A bordo del «Piemonte» e del «Lombardo» solo una donna: la moglie di Francesco Crispi.
Variegata, ma tutt’altro che bassa, la composizione sociale: 150 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti, 50 ingegneri, 60 possidenti, circa 500 tra artigiani e commercianti. A bordo del «Piemonte» e del «Lombardo» solo una donna: la moglie di Francesco Crispi. Una delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille», è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca.
Una delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille», è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca. Ad un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia e il secondo di Bergamo. Era l’ora del rancio e gli altri erano fermi a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora – scrive Garibaldi – era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».
Ad un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia e il secondo di Bergamo. Era l’ora del rancio e gli altri erano fermi a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora – scrive Garibaldi – era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».
 La situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi rispose: «Qui si fa l’Italia o si muore». Nella realtà pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».
La situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi rispose: «Qui si fa l’Italia o si muore». Nella realtà pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».