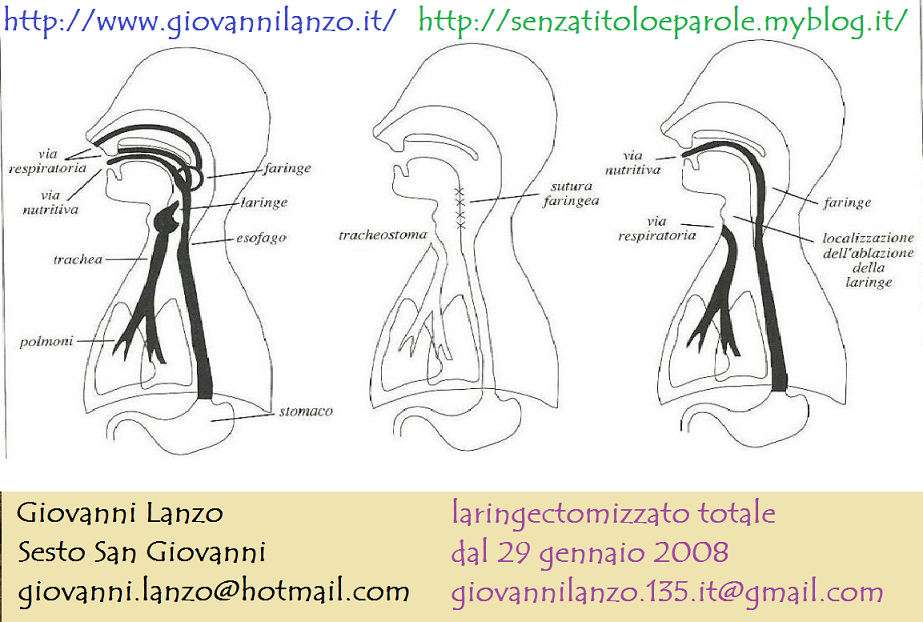By liotro
di alessandro garigliano
 Non avrei mai voluto scrivere una recensione su Philip Roth. Non avrei mai voluto esprimere un parere su un autore, celebrato in tutto il mondo, che scrive con una lingua piana, standard, al grado zero; che affronta argomenti rasoterra, penetrando all’interno di complicate, intime, vicende quotidiane o di correnti difficoltà esistenziali. Certo, attraverso il racconto di biografie comuni si spalancano sempre, in Roth, analisi di massimi sistemi, osservazioni su cruciali punti di svolta della Storia. Focalizzando il particolare, colmo di contraddizioni e di miserie, di generosità d’animo e di manie, Philip Roth, riesce a far riflettere i diversi contesti politici, sociali o economici. Ma i grandi e piccoli temi vengono sempre trattati senza alcuna ostentazione di forma, senza mai ricorrere a eccentricità retoriche perché la semplicità dei contenuti possa avere un’esposizione più seducente. Niente, ogni volta devo sopportare l’umiliazione di percorrere i romanzi di Philip Roth completamente rapito, malgrado sembri scorrere sulle pagine acqua, senza canali o altri argini, come se nessuno avesse progettato l’opera, controllato la struttura della trama, come se le parole e il montaggio delle scene non fossero stati da nessuno selezionati e rivisti con pedanteria, e anziché accadere quello che ogni manuale di retorica impone, vi sia solo, sempre, in ogni suo romanzo, una maledetta, torrenziale, incontrollata cascata d’ispirazione pura. Io so che non è così, lo so, ma l’effetto è quello, di un’opera d’arte composta senza sforzo.
Non avrei mai voluto scrivere una recensione su Philip Roth. Non avrei mai voluto esprimere un parere su un autore, celebrato in tutto il mondo, che scrive con una lingua piana, standard, al grado zero; che affronta argomenti rasoterra, penetrando all’interno di complicate, intime, vicende quotidiane o di correnti difficoltà esistenziali. Certo, attraverso il racconto di biografie comuni si spalancano sempre, in Roth, analisi di massimi sistemi, osservazioni su cruciali punti di svolta della Storia. Focalizzando il particolare, colmo di contraddizioni e di miserie, di generosità d’animo e di manie, Philip Roth, riesce a far riflettere i diversi contesti politici, sociali o economici. Ma i grandi e piccoli temi vengono sempre trattati senza alcuna ostentazione di forma, senza mai ricorrere a eccentricità retoriche perché la semplicità dei contenuti possa avere un’esposizione più seducente. Niente, ogni volta devo sopportare l’umiliazione di percorrere i romanzi di Philip Roth completamente rapito, malgrado sembri scorrere sulle pagine acqua, senza canali o altri argini, come se nessuno avesse progettato l’opera, controllato la struttura della trama, come se le parole e il montaggio delle scene non fossero stati da nessuno selezionati e rivisti con pedanteria, e anziché accadere quello che ogni manuale di retorica impone, vi sia solo, sempre, in ogni suo romanzo, una maledetta, torrenziale, incontrollata cascata d’ispirazione pura. Io so che non è così, lo so, ma l’effetto è quello, di un’opera d’arte composta senza sforzo.
Patrimonio è l’ennesimo capolavoro che leggo di Philip Roth. Con il sottotitolo Una storia vera, che per me è una specificazione respingente (l’ho iniziato a leggere per colpa di Giorgio Vasta che me l’ha consigliato). Da subito, ancora una volta con Roth, sono rimasto invischiato. La storia vera è quella di un figlio che accudisce il padre anziano, colpito da un tumore che gli deforma il volto. Il figlio, voce narrante e scrittore, diventa una sorta di infermiere. Com’è ovvio che sia, il racconto del passato del padre, la narrazione dei momenti principali delle proprie radici, c’è, ma non si tratta di un’immersione cieca, si ripercorre la storia del genitore con una delicatezza rara, si rammentano episodi salienti allo scopo di fare emergere la personalità della persona-personaggio, il profilo psicologico definito e complesso. Ma quello che più mi è piaciuto è la forza del figlio, che nel sostenere anima e corpo il padre, diventa ciò che proprio il padre definisce con una flagrante, impassibile e invidiabilmente schietta forma d’amore: una madre. Non un padre generoso, come anche il figlio si aspettava, ma la sintesi e la dilatazione dell’amore: una madre.
Voglio riportare un passo, che sebbene troppo lungo, dà netta l’immagine del tipo di rapporto che lega queste due generazioni in lotta, in concorrenza e in estenuante ma appagante dialogo.
Potreste dire che non significa molto per un figlio essere teneramente protettivo verso il proprio padre una volta che questi è senza forze e ridotto quasi al lumicino. Posso solo rispondere che mi sentivo altrettanto protettivo della sua vulnerabilità (come padre di famiglia emotivo e vulnerabile alle frizioni famigliari, come sostegno della famiglia vulnerabile agli incerti finanziari, come figlio incolto di immigrati ebrei vulnerabile ai pregiudizi sociali) quando io ero ancora a casa e lui era forte e sano e mi faceva diventare matto con consigli che erano inutili e limitazioni che non avevano senso e ragionamenti che mi spingevano, solo soletto nella mia stanza, a spaccarmi la testa contro il muro e urlare per la disperazione. Era proprio questa la discrepanza che aveva fatto del ripudio della sua autorità un conflitto così opprimente, così pieno di dolore e di scherno. Non era un padre qualunque, era il padre, con tutto ciò che c’è da odiare in un padre e tutto ciò che c’è da amare.
Così per tutto il libro, negli episodi più umilianti, quando la vergogna sopraffa la vecchiaia, nei momenti tragicomici, al cospetto della carcassa piagata del padre senescente, il figlio sta in soccorso con una forza innata e immotivata, concentrato a dare.
Cito ancora un brano che spiega il titolo, di quale patrimonio si tramanda l’eredità, quale sia il senso del dare, quale sia il timbro icastico della narrazione e con quanta forza si riflette su un padre che si è tragicamente smerdato:
Portai giù la federa puzzolente e la misi in un sacco nero della spazzatura che legai forte, e portai il sacco alla macchina e lo buttai nel bagagliaio per darlo in lavanderia. E perché questo era giusto e come doveva essere non avrebbe potuto essermi più chiaro, ora che il lavoro era finito. Questo, dunque, era il mio patrimonio. E non perché pulire fosse il simbolo di qualche altra cosa, ma proprio perché non lo era, perché non era altro, né più né meno, della realtà vissuta che era.
Ecco il mio patrimonio: non il denaro, non i tefillin, non la tazza per farsi la barba, ma la merda.
Ma la storia non è una definitiva inversione di ruoli tra un padre che ha educato il figlio infante e un figlio che adesso soccorre un padre nell’età senile. Avviene, attraverso la malattia e il bisogno, nel contatto assiduo tra le due generazioni, un mutuo dialogo dov’è naturale che entrambi, l’uno dall’altro, apprendano lezioni di vita. Ci si incanta a seguire il nitore dialettico con il quale la mortificazione o la prosaicità dell’anziano, ma anche il suo sano moralismo testardo, si completano e sono complementari alla capacità riflessiva del figlio, ma anche alla sua capacità di angosciarsi senza smarrirsi, di amare senza rimuovere l’odio filiale.
Nell’atto conclusivo della vita del genitore, il figlio scrittore, non può che manifestare testualmente la volontà di non volersi dimenticare nulla. Abbiamo assistito per tutto il libro alla travagliata agonia di un eroe ebreo che si è fatto da sé e che lentamente soccombe al tumore. Veglieremo anche sul narratore, quando, verso la fine, rischierà un attacco cardiaco, identificandosi con la condizione psicologica d’inesorabilità del padre. E ragioneremo sul fatto che probabilmente sarà in questa occasione, di impotenza e di fragilità, che l’autore maturerà la scelta di non volere applicare al padre nessuna forma di accanimento terapeutico, decidendo, e nel deciderlo destando un’emozione senza eguali, di lasciarlo andare.
E quando tutto sta per ultimarsi, quando sempre più netto trapela il dolore di Philip Roth nel registrare il decorso della malattia del padre, tra le righe di questa meditazione composta squilla stonato e urgente un urlo infantile che trascende lo stile del libro, la personalità del suo autore e noi umani lettori: perché dobbiamo morire? Una domanda che ormai nessun essere umano esplicita più e che pure è rimasta inevasa e irrisolvibile, e che nonostante l’evidenza di milioni di anni implode latente dall’alba dei tempi:perché dobbiamo morire?